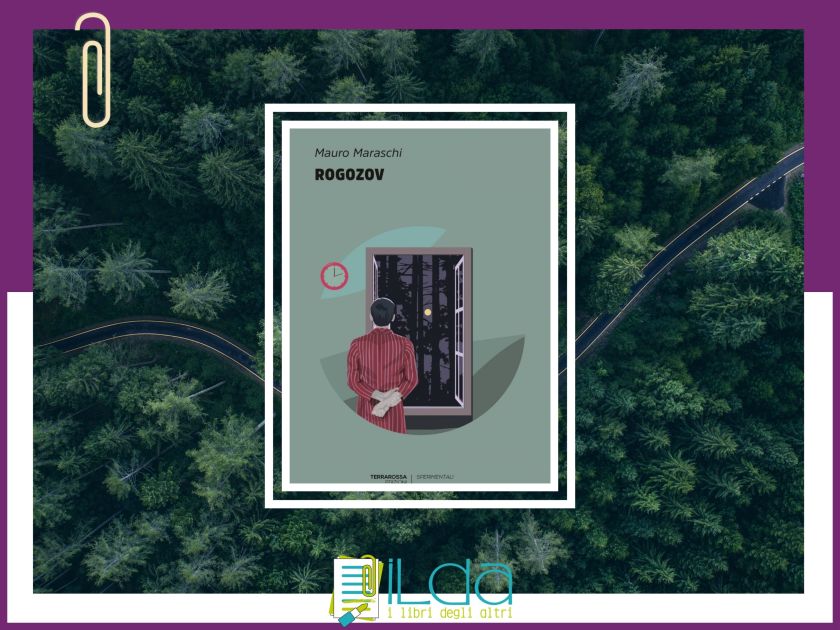di Mauro Maraschi
Da quando scrivo narrativa, e sono ormai vent’anni, il mio interesse principale è sempre stato quello di denunciare gli automatismi sociali e culturali. Sono consapevole che, come diceva Zamenhof, «una battaglia ideologica ne nasconde sempre una personale», e che in tal senso io non faccio eccezione. Combatto gli automatismi perché – in quanto individuo sociale – non li so cavalcare, non so trarne vantaggio, non sono mai riuscito ad adeguarmi. A un certo punto della mia esistenza ho cominciato ad avere la sensazione che la gente intorno a me non facesse niente per via di un’intenzione autentica, bensì selezionando delle opzioni da una gamma prestabilita. Con il passare degli anni tutto mi è sembrato sempre più retorico, stereotipato, predigerito – tutto mi è parso come una citazione di altro, e mai qualcosa in sé. Sempre più spesso durante una conversazione ho sentito il desiderio di trasformarla in una meta-conversazione, di ragionare sulla forma più che sul contenuto, o meglio, di correggere il tiro della forma per emanciparla dalle formule e farla coincidere il più possibile con il contenuto.
Va da sé che nella vita di tutti i giorni una simile tendenza si rivela disabilitante, soprattutto in contesti che non richiedono un’indagine dei sottotesti, come alle poste o durante una cena con amici. In qualsiasi contesto ho il desiderio di chiedere all’interlocutore: «Ma tu, davvero, cosa ne pensi? Al di là di quello che hai letto, al di là dell’opinione dominante e delle minoranze ideologiche – tu, un’idea tua e soltanto tua, te la sei fatta?». Eppure non lo chiedo più da vent’anni, da quando ho cominciato a scrivere nella speranza di risolvere il mio problema nero su bianco e di alleggerirmi l’esistenza dalla sensazione appena descritta. Non ci sono mai riuscito. E in verità quello che scrivo è di certo una battaglia agli automatismi, ma non lo è in modo esplicito, non ancora.
Scrivo anche per autocompiacimento, e immagino che sia così per tutti. Chiunque scriva spera di sentirsi dire che è bravo, che padroneggia la lingua, che sa raggiungere profondità inesplorate del sentimento e dell’intelletto. Chiunque scriva spera di leggere recensioni encomiastiche, di far parte di un giro o di una giuria, di poter insegnare ad altri la propria arte. Chiunque scriva spera di potersi sentire speciale, unico, insostituibile. Per quanta umiltà possa dimostrare, e per quanto nobili possano essere i suoi temi, chi sostiene di scrivere per il bene dell’umanità mente innanzitutto a sé stesso. La letteratura non ha questo potere, non può redimere i popoli e nemmeno l’individuo. Dicono che vogliono risvegliare le coscienze e sensibilizzare le masse, e allora scrivono di temi sociali, di razzismo e di mille altre cose che quasi mai li riguardano in modo personale: scelgono un tema forte, che possa coinvolgere il numero maggiore di persone, e lo svolgono, quel tema, come a scuola. Non metto in dubbio che siano mossi da sincera commozione nei confronti di drammi universali o individuali, ma quello che vogliono più di ogni altra cosa non è rendere giustizia a quei drammi, bensì essere encomiati per averlo fatto così bene. Il bene però lo si fa in disparte, in silenzio; non lo si annuncia in un post, non lo si trasforma in una mostrina: nello stesso istante in cui rivendichi una tua buona azione la stai mortificando. Ecco perché secondo me si scrive innanzitutto per narcisismo. Anche perché nella maggior parte dei casi scrivere è un privilegio concesso a chi ha già delle sicurezze economiche (che di rado provengono dalla scrittura) ed è avvantaggiato da fattori relazionali, sociali e persino geografici. Ma un privilegiato cosa può insegnare alla massa? E soprattutto, gli interessa davvero farle del bene?
I libri non possono cambiare il mondo, non ci sono mai riusciti e mai ci riusciranno. Scrivere e leggere sono distrazioni dal pensiero assillante della morte, distrazioni peraltro nobilitanti. La lettura non ci rende persone migliori (di certo avere una cultura di base alimenta il senso civico, ma oltre una certa soglia ci rende soltanto più intolleranti verso l’ignoranza). L’ha detto anche Calasso: «Uno può leggere mille libri l’anno e rimanere comunque uno stronzo». Meno che mai la quantità è proporzionale alla crescita interiore, perché in molti leggono soltanto libri inutili, oppure leggono i libri migliori ma non li capiscono o li fraintendono o non sanno che farsene dei loro insegnamenti. Molto meglio leggere poco ma seguendo un proprio percorso e non arrancando dietro le ultime uscite pur di non essere esclusi dal dibattito collettivo delle bolle culturali. La lettura è una passione, non uno strumento di redenzione dei popoli, né di sé stessi. E così la scrittura, che per quanto alta rimane un prodotto di intrattenimento (può essere un intrattenimento altissimo, vertiginoso, ma proprio perché intrattiene persone coltissime è difficile che riesca a elevarle ancora più in alto: con maggiore probabilità le renderà soltanto più snob).
Scrivo anche perché non so parlare. Vivo subendo costanti soprusi da chiunque, sempre e comunque legati al piano comunicativo. Con la gente della massa sono troppo lento, troppo relativista: il tempo di spiegare le mie motivazioni e già in tre mi hanno superato nella fila alle poste. In mezzo al traffico non ho mai rimproverato nessuno, perché immagino sempre che abbiano tutti ragione: «di certo quello che è appena passato con il rosso non lo fa ogni giorno, è stato un caso, un giorno potrebbe succedere a me, non posso giudicare nessuno in base a un singolo errore»; oppure «Di certo la signora che è stata sgarbata al supermercato – con me, per pochi secondi – è una persona adorabile per la quasi totalità del resto della sua vita – con i suoi cari, per anni». Io in mezzo alla massa perdo sempre. Ma perdo anche nel dialogo con l’élite culturale: non me la sento di dire agli altri che danno troppo peso a ciò che fanno o dicono o pubblicano, non capisco nemmeno con quale faccia possano parlare con tanta convinzione di un prodotto culturale da loro concepito; trovo infantile la sacralità attribuita alla letteratura; la maggior parte delle volte davanti a una presentazione o a un’intervista mi chiedo: «Ma cosa sta dicendo?». Come si può affermare una verità individuale con quel sorrisetto lì? Come fanno? Io non ci riesco. Non c’è affermazione che non farei seguire da «in questo caso», «con queste eccezioni», «in questo contesto» e così via. È tutto talmente relativo che non riesco a scegliere le parole e le affermazioni. E così quando di rado tocca a me tenere le redini di una presentazione ecco che ai più appaio alienato o persino impreparato. Alla fine dell’ultima presentazione di Io cammino da solo, la selezione dei diari di Thoreau da me curata per Piano B, una persona del pubblico mi ha detto: «Sembrava che non sapessi nemmeno tu perché eri lì». E a conti fatti aveva ragione. Non so interpretare il ruolo dell’intellettuale in tempo reale, perché non credo che l’autore abbia l’obbligo della performance e mi sento ridicolo a dare al pubblico ciò che vuole, mi sento un animale ammaestrato.
E allora scrivo, in silenzio e in disparte (non potrebbe essere altrimenti), per autocompiacimento, perché non so parlare, e perché spero di dare conforto a quelli come me, se ancora esistono. I timidi. Che fine hanno fatto i timidi? Quelli veri, dico. Oggi i timidi scrivono libri sulla propria timidezza, fanno presentazioni in cui parlano della propria timidezza, si esibiscono su un palco e poi chiariscono che sono timidi. Ma non è vero. Un timido non lo sa nessuno che è timido. Dall’esterno può anche sembrare una persona normale ma poi lo riconosci perché si esprime di rado, non fa presentazioni, non si esibisce su un palco, e nessuno lo vede nemmeno essere timido, perché si è timidi in disparte, il timido esprime il massimo della propria timidezza sottraendosi al mondo, non andando nel mondo e facendone sfoggio per essere applaudito.
Quando ero più giovane, quando ancora la letteratura mi emozionava in modo immediato, i libri mi hanno fatto sentire meno solo. Non che mi «rintanassi nei libri», come si dice: avevo molti amici, uscivo sempre, ridevo, amavo. Soltanto che poi tornavo a casa e qualsiasi cosa avessi fatto mi sembrava un’illusione, un sogno, una recita, perché di fatto la vita sociale è questo, una recita. Siamo noi stessi soltanto quando siamo soli. E allora io tornavo a casa e mi sentivo me stesso soltanto leggendo di Moscarda o di Verchovenskij o di Dupin. Con gli anni le mie letture si sono fatte più complesse, più ricercate, ma ho continuato a trovare conforto nello scoprire che da qualche parte, nel mondo reale o nella mente di qualche scrittore, erano esistiti individui ridicoli immersi in un profondo disagio esistenziale: un Chandos che non riesce più a comunicare, uno Squalificato che per sopportare la vita deve fare il buffone, un Rudolf che addebita alla sorella la propria incapacità di iniziare a scrivere un saggio su Mendelssohn. Per buona parte della mia vita leggere di questi personaggi è stato di conforto. Poi qualcosa si è rotto, si è forse esaurito il bacino cui attingere, e mi è rimasta quasi soltanto la saggistica.
Ora, se devo riassumere in poche parole i motivi per i quali scrivo posso riassumerli così: «Memore della solitudine provata negli anni della formazione, e di averla vissuta in disparte e mai su un palco, vorrei dare conforto a quell’ormai esigua minoranza di individui che non sa/non vuole esprimere la propria solitudine su un palco». Si tratta comunque di autocompiacimento, perché quando uno vuole dare conforto a chi vive una situazione da lui già vissuta non lo fa per gli altri ma per sé stesso, da un lato per sentirsi utile e dall’altro per illudersi di poter rivivere attraverso la vita altrui. Siamo anzi di fronte a un doppio autocompiacimento. Però posso testimoniare che l’ormai esigua minoranza di cui faccio parte (per capirci, quelli che non si esprimono mai sui temi caldi del momento, che non rivendicano i micro-diritti quotidiani, che non si esibiscono su un palco), questa ormai esigua minoranza non sa più che pesci pigliare, non sta bene nella società né sui social, ha spesso tanto da dire (o comunque non meno di chi parla e scrive in continuazione) ma soffre a tenersi tutto dentro e non potrebbe fare altrimenti. Il mio obiettivo a lungo termine è pertanto duplice: da un lato, insinuare dei dubbi in tutti coloro che vivono invece senza intoppi gli automatismi della quotidianità, suggerire loro che ciò che fanno non è poi così importante, che sono soltanto dei fili d’erba su un prato, che non sanno nemmeno perché hanno messo su famiglia, e che comunque la loro vita, che a loro pare normale e inevitabile, è in realtà una vita insulsa e insignificante e immeritevole d’essere vissuta; dall’altro, spronare i pochi viventi di Montale a uscire dalle tenebre come i mammiferi dopo l’estinzione dei dinosauri.
Mauro Maraschi è nato a Palermo nel 1978. Si occupa di traduzione e redazione per diverse case editrici. È stato editor della narrativa italiana per Hacca, per la quale ha anche curato l’antologia ESC, Quando tutto finisce (2012). Nel 2013 ha partecipato alla prima edizione di Pianissimo, Libri sulla strada, progetto di Filippo Nicosia. Due tra le sue ultime traduzioni sono Complex TV di Jason Mittell (minimum fax, 2017) e Masscult e Midcult di Dwight Macdonald (Piano B Edizioni, 2018).