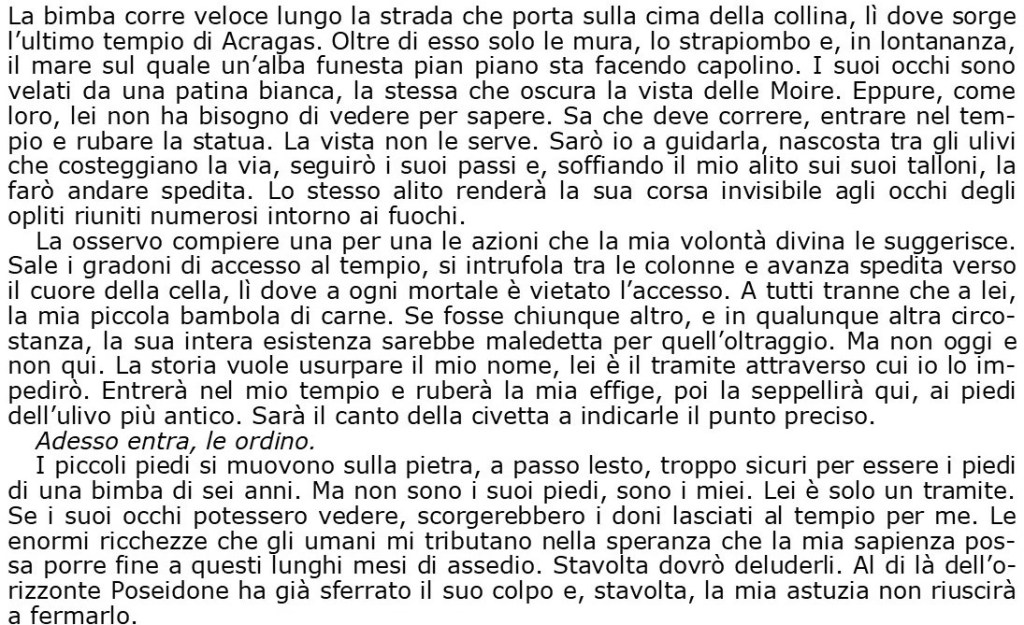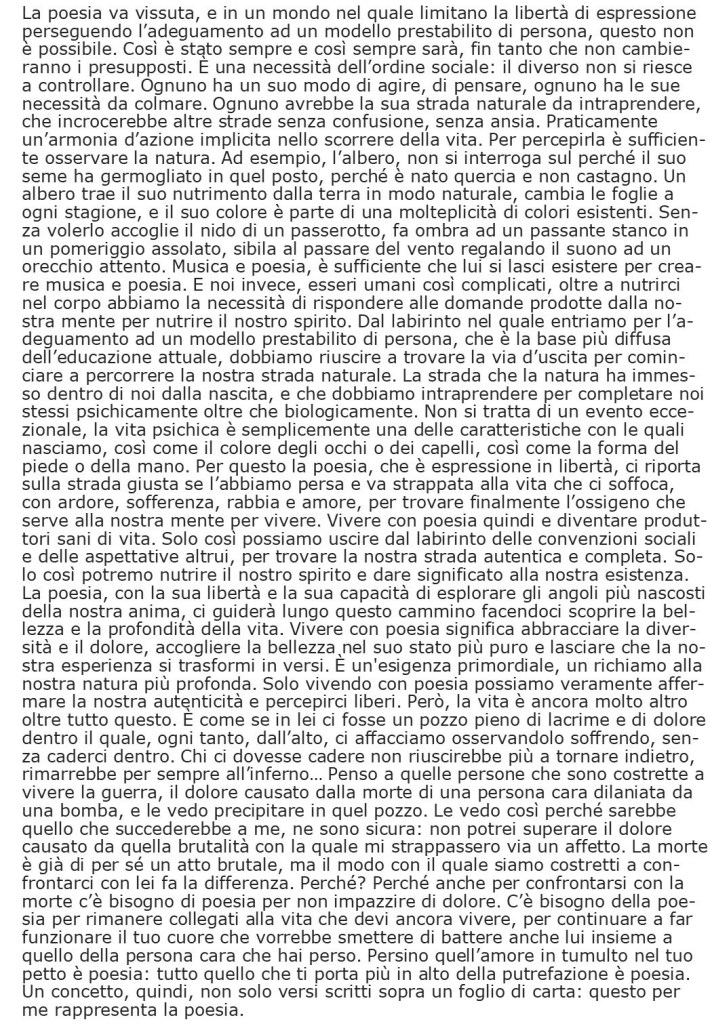Hai presente la posta del cuore?
Postilla è la posta del cuore per autori inediti. Tratterà di scrittura piuttosto che d’amore, ma per il resto la formula è la stessa: scrivi a Francesca de Lena e lei ti risponderà.
Per partecipare leggi qui.

Cara Sara,
perdonami per averci messo tanto.
Mi chiedi degli elenchi e dei periodi lunghi, temi che rallentino il ritmo. In realtà io qui non trovo né periodi lunghi né chissà che elenchi, quindi direi che questo pericolo è scongiurato. Quello che vedo, però, è un’immagine attorcigliata su sé stessa, e quindi statica. Ed è questo il problema che rallenta il ritmo, ed è un problema anche perché dimostra il contrario di ciò che racconta: tu vuoi una dinamica elettrica, urlata, nervosa, al limite del crollo. Ma ci insisti troppo su, senza immaginarne cause e conseguenze, senza uno sguardo laterale che la inquadri da un punto di vista inaspettato, e quindi la sprechi.
Il testo potrebbe dividersi in due metà: le descrizioni relative alla madre, le descrizioni relative al figlio (e già questo, la dicotomia, tende a rinchiuderti: le aperture le danno le terne di elementi). Madre:
Non era mai sola/Mai un cazzo di momento in cui potesse sedersi e lasciare andare la testa/C’erano urla che le aprivano crepe nel cervello/lei tremendamente lenta/Parlare e non sentire quello che le rispondevano/Condannata a sorridere senza riuscire a seguire un filo, senza essere in grado di formulare una frase di senso/così inutile, così trasparente, così fastidiosa a livello di decibel/sulla lingua nessuna parola giusta o connessione logica/Ci aveva provato, a capirlo, mille e mille volte/Alcune sere aveva urlato anche lei, era diventata pazza/avrebbe voluto ingoiarsi la lingua, e si era schiacciata forte la testa tra i palmi.
Figlio:
un essere attaccato al polpaccio/quegli artigli aggrappati ai jeans, la chiazza di moccio e lacrime a metà gamba/un ululato/l’urlo metteva in fuga/quegli occhi strizzati/i pianti non smettevano mai, quasi mai.
La pagina è fatta sostanzialmente di un’unica informazione: c’è un bambino che piange, e una madre esausta. Le possibilità di apertura, di dinamismo dell’immagine, te le danno: lo slalom sul marciapiede oppure un evento con terzi (festa, riunione, appuntamento con il responsabile) oppure l’uscita di casa sbattendo la porta. Prendi una di queste strade e approfondiscila, tutte insieme si indeboliscono, si fanno ripetitive (nella selezione, prediligere le immagini meno note: meglio gli artigli aggrappati ai jeans, la chiazza di moccio e lacrime a metà gamba piuttosto che le urla che le aprivano crepe nel cervello), e soprattutto astratte, generiche, sempreverdi. Se il problema è generico, lo diventa anche la soluzione (allattamento), per cui finiremo per leggere di un generico esaurimento nervoso della madre che allatta un bambino piangente, come se fosse un tropo riconoscibile da sé (e allora perché raccontarlo?) invece che la specifica vicenda di questa specifica madre del tuo racconto, con il suo specifico bambino. Scegli cosa raccontare di loro, del loro intimo conflitto (si vergognava di lui) e non rifugiarti nelle immagini rappresentative di tutte le madri, perché quelle in realtà non ne rappresentano nessuna.
Ciao, buona scrittura 😊
Francesca